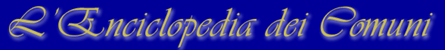San
Costanzo è un comune italiano di 4.932 abitanti
della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.
San
Costanzo è un comune italiano di 4.932 abitanti
della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.
ETIMOLOGIA
Un'antichissima e consolidata tradizione vuole che
San Costanzo si chiamasse originariamente Monte Campanaro
che, in seguito al dono di una preziosa reliquia del
braccio di San Costanzo martire (140 - 175 d.C.) da
parte di una nobildonna di Perugia, avrebbe cambiato
nome. Nella realtà, dall'esame di numerosi
ed autorevoli documenti contenuti nel volume di Paolo
Vitali "Storia di San Costanzo dalle Origini
al XIX Secolo", quali il "Codex Diplomaticus
Dominii Temporalis S. Sedis" e le " Rationes
Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV - Marchia",
si può con assoluta certezza affermare, che
il castello di San Costanzo e quello di Monte Campanaro
si trovavano territorialmente vicini ma tra loro ben
distinti. Il nome San Costanzo sarebbe in realtà
un agiotoponimo (nome di luogo che si identifica con
quello di un santo) e risalirebbe al periodo altomedievale
della dominazione bizantina (VI secolo d.C.). Nel
territorio esisteva certamente una piccola cappella
o altare campestre intitolato al vescovo Costanzo
martirizzato il 29 gennaio 175 d.C. e, da questo culto,
originò il nome della località San Costanzo
seguendo una consuetudine a quel tempo diffusissima.
La reliquia del Santo protettore è effettivamente
conservata negli archivi della chiesa collegiata.
La sua presenza è attestata da un documento
dell'archivio vescovile di Fano già nel 1734.
Nel corso dei secoli i vari vescovi hanno rilasciato
lettere di autenticità; l'ultima è di
Sua Eccellenza Vincenzo Franceschini in data 26 maggio
1906: "Vincentius Franceschini Dei et Apostolicae
Sedis Gratia Episcopus Fanensis ac eidem Sanctae Sedi
immediate subiectus Universis, et singulis praesentes
literas inspecturis fidem facimus, et attestamur,
Nos ad majorem Omnipotentis Dei gloriam, suorumque
Sanctorum venerationem recognivisse sacras particulas
de Brachii S. Constantii Martiris quas ex authenticis
locis extracta reverenter collocavimus in Urna lignea
inaurata rettangularis figurae, crystallis munita
bene clausa, et funicolo serico coloris rubri colligata,
ac sigillo nostro signata, easque consignavimus cum
facultate apud se retinendi, aliis donandi, et in
quacumque Ecclesia, Oratorio, aut Cappella publicae
Fidelium venerationis exponendi. In quorum fidem has
literas testimoniales manu nostra subscriptas, nostroque
sigillo firmatas per infrascriptum Sacrarum Reliquiarum
Custodem expediri mandavimus. Fani ex Aedibus nostris
Episcop. Die 26 Mensis Maii Anni 1906".
LE
MURA
Nel V-IV secolo a.C. San Costanzo era un pagus o vicus,
un villaggio di campagna dove agricoltura e pastorizia
formavano la maggiore occupazione; vista però
la posizione strategica ai confini della Gallia cisalpina
è assai probabile che vi fossero stanziate
guarnigioni romane, incaricate del controllo di questa
zona cuscinetto. Le prime fortificazioni furono erette
intorno al VI secolo d.C., a completamento di una
posizione geografica militarmente favorevole, in un
periodo che potremmo collocare dopo la devastante
guerra gotico-bizantina e prima della venuta in Italia
dei Longobardi. Molte genti delle zone costiere andavano
ad accrescere i primi insediamenti collinari, che
offrivano una maggiore possibilità di difesa
dalle continue invasioni barbariche. Nel 1283 (Codex
Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis) San Costanzo
era uno dei castelli che formavano il Comitato di
Fano, le fonti del periodo sono tuttavia mute quanto
ad informazioni sulla costruzione e conformazione
della cinta muraria. Con i Malatesta gli interventi
a favore delle mura si fecero frequenti e finalmente
suffragati da riscontri di archivio. Nel 1349 il castello
venne riparato sotto la supervisione del capitano
Cello di Chompangniuccio per i danni subiti durante
un incendio demmo e paghammo a Cello di Chompangniuccio
di XXII d'aghosto perche fue mandato a Sanghostanzo
per chapitano quando il chastello arse per fallo chonciare
… libre XV (SASFa, ASC, Depositaria, reg.6,c.87r),
circostanza da ricondursi comunque ad eventi non bellici
visto che San Costanzo, in quell'anno, non fu coinvolto
in alcuna azione militare. Nel 1429 Galeotto Roberto
Malatesta, responsabile amministrativo per conto dei
più giovani fratelli, in linea con una deliberazione
del Consiglio generale di Fano del 17 dicembre, accondiscende
alla ristrutturazione delle mura diroccate del nostro
castello, che avevano risentito delle frequenti ribellioni
e conseguenti riconquiste dal 1410 al 1416. I lavori
del 1429 furono certamente fra i più importanti
e, molto probabilmente, delinearono l'assetto definitivo
con struttura scarpata del perimetro che, pur con
innumerevoli rimaneggiamenti, è giunto fino
a noi. Si è ipotizzato un intervento, nella
fortificazione delle mura di San Costanzo, da parte
dell'architetto Francesco di Giorgio Martini. L'intervento
del famoso architetto militare, al servizio della
corte feltresca, verrebbe a collocarsi durante la
signoria di Giovanni Della Rovere che, nel 1474, fu
infeudato dallo zio Sisto IV della Città di
Senigallia con relativo contado e del vicariato di
Mondavio che includeva anche il castello di San Costanzo.
Tuttavia l'ipotesi di un diretto coinvolgimento di
Francesco di Giorgio Martini relativamente alle mura
di San Costanzo, peraltro non confortata da nessuna
fonte storica, deve essere criticamente rivista. Alcuni
preziosi documenti, rinvenuti nell'archivio vescovile
di Fano hanno permesso di stabilire con certezza che
il complesso torre-chiesa venne edificato solo a partire
dal 1570, circa settanta anni dopo la morte dell'architetto
senese. Nella concezione antropomorfa martiniana verrebbe
quindi a mancare un elemento fondamentale che, al
tempo dell'ipotizzato intervento, non era ancora in
essere. Tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo,
nel settore meridionale della cinta muraria, quello
prospiciente l'attuale piazza Perticari, venne costruito
il palazzo del Pubblico o palazzo della Comunità
dove prese stabile residenza il Podestà. Da
alcune missive, conservate nell'archivio parrocchiale
di San Costanzo, sappiamo che nell'anno 1899 i torrioni
e gran parte delle mura conservavano intatta la loro
forma primitiva. Nella prima metà del ventesimo
secolo, la quasi totalità della cinta muraria
compreso il torrione nord-orientale, quello sud-occidentale
(Torrione Tomani) e la porta settentrionale del castello,
hanno subito dei radicali e sconsiderati interventi
che hanno completamente alterato l'architettura e
la funzione originaria della struttura. È stato
invece risparmiato il torrione nord-occidentale ed
un piccolo tratto di mura adiacenti.
ORIGINI
E CENNI STORICI
I numerosi reperti archeologici datano all'VIII secolo
a.C. la presenza dei primi villaggi nel territorio
di San Costanzo: siamo agli inizi dell'età
del ferro che si identifica, nel centro collinare,
con la civiltà dei Piceni. A San Costanzo è
stata rinvenuta una delle più antiche ed importanti
necropoli picene. L'insediamento dei Piceni avrebbe
avuto inizio nell'VIII secolo a.C. ed un suo consolidamento
nei secoli VII e VI a.C. È inoltre ipotizzabile
la presenza di un insediamento di Etruschi intorno
al VI - V secolo a.C. Più avanti negli anni
nel territorio dove oggi si trova San Costanzo venne
a formarsi un pagus o vicus romano, un villaggio di
campagna dove agricoltura e pastorizia formavano la
maggiore occupazione; vista però la posizione
strategica ai confini della Gallia cisalpina è
assai probabile che vi fossero stanziate guarnigioni
romane, incaricate del controllo di questa "zona
cuscinetto". San Costanzo, con altri centri limitrofi,
si trovava sulla direttrice della via Gallica, che
permetteva di scendere agilmente dalle colline verso
il mare e viceversa. In virtù della particolarissima
geografia fu di primo piano il coinvolgimento di San
Costanzo in una delle più importanti battaglie
della storia, quella conosciuta come battaglia del
Metauro (207 a.C.). A questo periodo risalgono le
prime fortificazioni difensive sulle alture di San
Costanzo. Molti abitanti delle zone costiere andavano
ad accrescere i numerosi insediamenti collinari, che
offrivano maggiore possibilità di difesa dalle
continue invasioni barbariche e dalla sanguinosa guerra
gotico - bizantina che ebbe inizio nel 535 e trovò
il suo epilogo solo nel 553. Al termine del conflitto
gotico - bizantino e con la comparsa delle prime fortificazioni,
San Costanzo viene ad assumere una più decisa
rilevanza strategica pronto ad opporsi ad una nuova
e temibile invasione che non si farà attendere,
quella da parte dei Longobardi. Nel territorio di
San Costanzo esistono svariati riscontri topografici
segni certi della presenza dei Longobardi e dei popoli
giunti al loro seguito: esempi fra i tanti Valdeprati
che deriverebbe da Waldipert (toponimo longobardo
da nome personale) e Montelibino (Monte di Libino)
tipico toponimo longobardo di tipo settimànico
(nome di persona preceduto da un appellativo). Altro
toponimo settimànico è Fontanamaggio
(Fontana di Magio o Maio). Con i Longobardi giunsero
in Italia, a più riprese, altri popoli: i Sarmati,
i Pannoni, i Gepidi, i Suavi, i Norci ed i Bulgari.
L'antica presenza di questi ultimi, nel territorio
di San Costanzo, è testimoniata da alcuni significativi
toponimi quali Monte Bugaro, Rio Bugaro e Monte Bugra.
Dopo l'appartenenza nel VI secolo alla Pentapoli marittima
controllata dall'Esarca di Ravenna, San Costanzo,
in virtù delle numerose concessioni imperiali,
passa sotto il dominio dei Romani Pontefici. Nel 1283,
come si evince dal Codex Diplomaticus Dominii Temporalis
S. Sedis, è parte del contado di Fano. Dagli
inizi del 1300 sarà la famiglia guelfa dei
Malatesta ad esercitarne il diretto controllo. Nel
1434 il castello di San Costanzo risulta annesso al
vicariato di Mondavio. Tre anni più tardi Sigismondo
Malatesta cede a Bartolomeo del Palazzo la terra di
San Costanzo ormai smembrata dal resto del vicariato;
nel 1440 lo stesso Malatesta la riunirà ai
suoi stati permutandola con Barchi e la Villa di San
Sebastiano. Sei anni dopo San Costanzo, parte del
vicariato, è ceduto a Fano da papa Eugenio
IV con la bolla Licet Summorum Predecessorum Nostrorum
del 13 aprile 1446. Venuta meno la fortuna dei Malatesta,
con le capitolazioni del 25 settembre 1463 Fano ed
i suoi territori tornano ad essere soggetti alla Sede
Apostolica. Papa Pio II, il 28 novembre 1463, con
la bolla Inter Multiplices Curas investe del vicariato
suo nipote Antonio Piccolomini. Terminata la breve
signoria dei Piccolomini con la morte di Pio II, San
Costanzo torna sotto il controllo di Fano. Eletto
quindi papa Sisto IV, il vicariato viene ceduto a
Giovanni Della Rovere con la bolla Universalis Ecclesie
Regimini del 12 ottobre 1474. Il duca Francesco Maria,
nel 1512, concede in feudo il castello di San Costanzo
all'antica e nobile famiglia milanese dei Landriani,
nella persona del capitano Ambrogio. Con l'elezione
al pontificato di papa Leone X, il Della Rovere vede
vacillare la stabilità del proprio potere:
nel 1517 è Lorenzo de' Medici ad occupare la
terra di San Costanzo. Più avanti negli anni
persistendo papa Leone X nel disegno di smembrare
il ducato, cede nuovamente a Fano il vicariato di
Mondavio e con esso San Costanzo (bolla Ad Apostolicae
Dignitatis Apicem del 26 maggio 1520). Più
tardi i Della Rovere, vedendosi nuovamente arridere
la fortuna, recupereranno senza colpo ferire i territori
loro appartenuti. Nel 1631, con la morte dell'ultimo
duca Francesco Maria II, il Ducato di Urbino e con
esso San Costanzo passa alla Santa Sede. Venuta meno
la successione dei Della Rovere, lo Stato di Urbino
passa alla Santa Sede assumendo il titolo di legazione.
Della Legazione di Urbino faceva parte anche San Costanzo.
In questo periodo la terra, delimitata dalle mura
castellane, al cui interno si trovava la piazza Grande
ed il corso, andava perdendo la propria centralità
a favore del borgo: qui si andavano sviluppando le
botteghe di artigiani, il barbiere, il fabbro, il
fornaio, il calzolaio, lo speziale anche se l'agricoltura,
con una buona produzione di grano, olio e vino era
la fonte di maggiori entrate per l'economia del tempo.
Il territorio di San Costanzo era diviso in contrade,
fra queste le più importanti erano contrada
del Castello, la contrada San Silvestro (dal nome
della chiesa omonima) e la contrada Sant'Agostino
(dal nome del convento degli Agostiniani). Come in
altri piccoli centri a San Costanzo risiede il Podestà,
ospitato nel palazzo Magistrale, in diretti e frequenti
contatti con il Cardinale Legato e l'Arciprete del
luogo. Si ha notizia di una grave emergenza per la
presenza di pirati (anno 1672): si trattava di bande
di Turchi più o meno organizzate che, provenienti
dal mare, interessarono per alcuni anni il litorale
e le zone adiacenti con le loro incursioni. Si ha
notizia di un mal contaggioso, probabile pestilenza
che interessò San Costanzo dal 1731 al 1737.
Negli anni 1738 e 1739 si ebbe il male epidemico,
violenta e grave epidemia fra gli animali bovini.
Dal 1742 al 1746 si segnala il passaggio a San Costanzo
di truppe alemanne: in questo periodo l'Europa e la
penisola erano coinvolte in un'aspra lotta di successione,
iniziata con la morte dell'imperatore Carlo VI il
20 ottobre 1740. Altro fatto saliente che ha interessato
San Costanzo nella seconda metà del settecento
è stata la riforma del locale catasto. Dal
1797 al 1814 San Costanzo visse i fatti d'arme, che
si susseguirono ad un ritmo incalzante ed inusitato,
in seguito all'arrivo in Italia del giovane generale
Napoleone Bonaparte. Il 19 marzo 1801 si fermarono
a San Costanzo tre dragoni francesi di cavalleria
e la piccola comunità dovette provvedere a
tutte le necessità della guarnigione. Le Marche,
sottratte al controllo del Pontefice, vennero suddivise
in Dipartimenti: il comune di San Costanzo faceva
parte del Dipartimento del Metauro - Distretto di
Senigallia. Dopo la sconfitta subita da Napoleone
a Lipsia (ottobre 1813) e la firma dell'armistizio
con gli austriaci (16 aprile 1814), San Costanzo tornava
nuovamente sotto il controllo della Santa Sede. Rimaneva
comunque il comune principale ed aveva come appodiati
Cerasa e Stacciola. Tra la fine del XVIII e l'inizio
del XIX secolo San Costanzo ebbe fama di dotta ed
ospitale cittadina. Da Fano e Pesaro si saliva volentieri
su in collina, che alla felicissima posizione geografica
univa un clima salubre ed un vivere tranquillo. Era
in uso trascorrervi la primavera e l'estate, periodi
che offrivano ai forestieri emozioni particolari.
Anche l'inverno, abbondante di neve, aveva un suo
fascino nelle case del Borgo e nei palazzi aristocratici
del centro. Il conte Francesco Cassi amava spesso
soggiornare a San Costanzo dove possedeva una splendida
residenza. Gli inviti in casa Cassi erano frequenti,
con le più importanti personalità del
momento che passavano qui, ben volentieri, un po'
del loro tempo. Si andavano formando cenacoli di artisti
e letterati, si leggevano i classici, ci si misurava
in recitazione nelle residenze gentilizie o nel Teatro
Della Concordia (1721). Questo periodo di locale rinascimento
sarà interrotto dai luttuosi eventi del 1822,
che porteranno il piccolo centro alla ribalta delle
cronache nazionali. Il 26 giugno 1822 moriva a San
Costanzo, in casa del cugino conte Cassi, il letterato
Giulio Perticari. Della morte fu ingiustamente accusata
la bellissima moglie del Perticari, Costanza, figlia
di Vincenzo Monti e Teresa Pikler. In realtà
il conte Giulio Perticari morì per una grave
malattia al fegato, che aveva manifestato i suoi primi
sintomi fin dai primi anni di matrimonio. L'atto di
morte del conte Perticari si conserva negli archivi
della Collegiata.